SaqqaraNox
Active member
- Joined
- Oct 9, 2021
- Messages
- 890
Plutarch
PLUTARCO
Sommo Sacerdote di Apollo
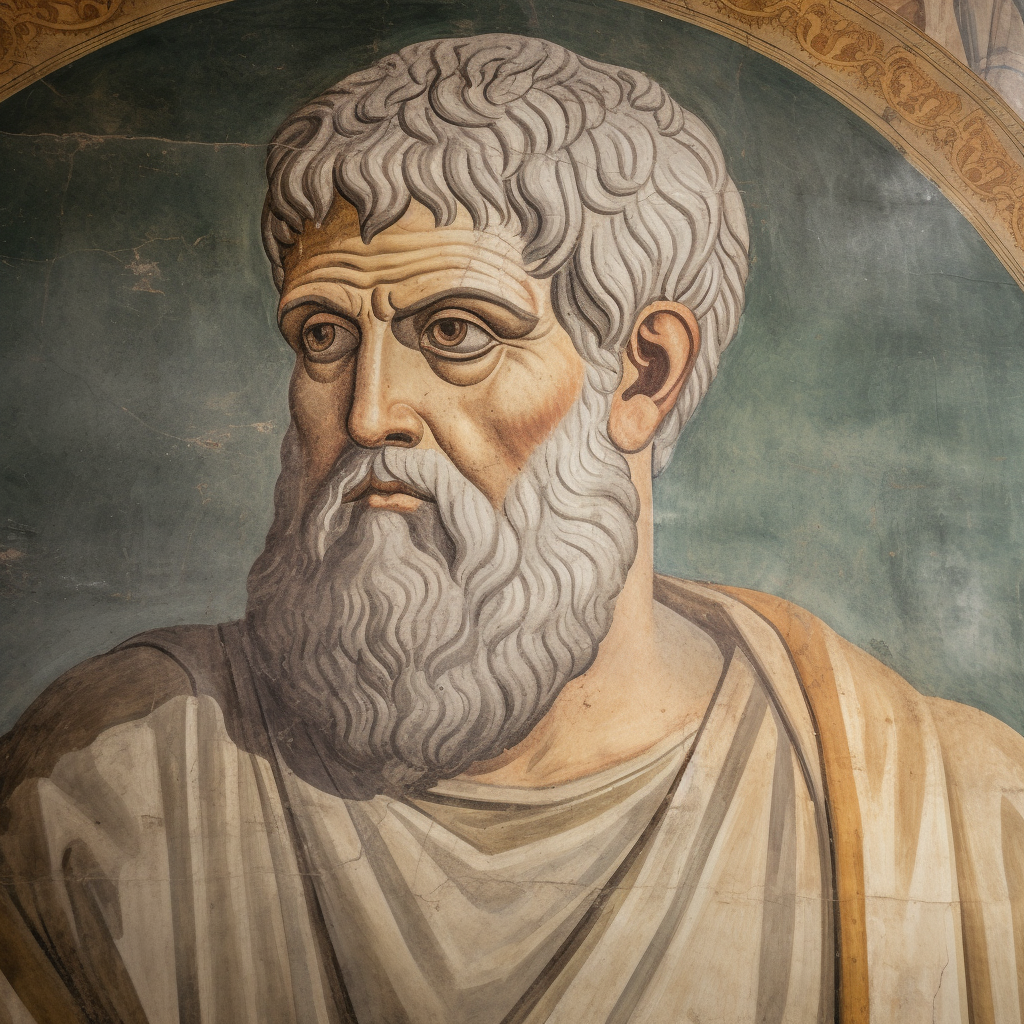
Il grande Plutarco si è fatto un nome nella storia come uno dei più celebri storici dell’antichità. È tuttora frequentemente citato in tutti i dipartimenti di storia e di studi classici. La sua serie delle Vite, che consiste in ampie biografie doppie di importanti figure dell’antichità, costituisce una parte straordinaria di ciò che sappiamo su quell’epoca. Il grande storico ha fornito instancabilmente, a generazioni di storici, conoscenze e contesto adeguati per comprendere la cultura degli Dèi.
Tuttavia, ai suoi tempi, Plutarco era soprattutto un Sommo Sacerdote di Apollo a Delfi, oltre che un autore di grande rilievo religioso e morale per i romani della sua epoca. Fu un pioniere in molti ambiti della conservazione culturale, storica e ambientale, sostenuto dal circolo dell’imperatore Vespasiano. In età avanzata, fu anche un associato dell’imperatore Adriano, che divenne suo benefattore e alleato nella promozione della cultura greca. Questo aspetto dello scrittore greco è stato comunemente dimenticato dalle masse, una questione che desideriamo correggere nel riconoscere l’immensa importanza di questo amico degli Dèi.
FIORE TRA LE ROVINE
Plutarco nacque a Cheronea, luogo della celebre battaglia di Filippo e Alessandro tre secoli prima. La sua famiglia era di rilievo e benestante, equivalente al rango equestre romano. Crescendo, fu estremamente legato ai suoi fratelli e venerava suo fratello Timone. Anche suo nonno Lampria compare nei suoi dialoghi, a testimonianza della stima che il giovane greco nutriva per la sua famiglia.
Suo padre, Autobulo, era un grande conversatore e uomo di società; spesso organizzava cene con personalità influenti tra i romani, alle quali il figlio curioso assisteva con vivo interesse. I resoconti di queste serate sarebbero poi divenuti oggetto dei cosiddetti libri Conversazioni a tavola di Plutarco. Fin da giovane, Plutarco fu affascinato dalle persone e dotato di una straordinaria coscienza sociale, con una memoria prodigiosa per volti, nomi e dettagli delle conversazioni, che il padre contribuì ampiamente ad alimentare:
In generale, le sue effusive riunioni familiari forniscono gran parte dello slancio alla sua produzione letteraria. Menziona che la sua famiglia celebrava festività in onore di Socrate e Platone, simili a quelle che saranno tenute da Proclo quattro secoli più tardi. Plutarco presenta molte delle sue opere come celebrative e nello spirito di un particolare calore, cosa che le rende, ancora oggi, trascendentemente leggibili.
Eppure, nonostante l’agiatezza dell’ambiente in cui crebbe, Plutarco nacque anche in un’epoca di grande inquietudine e problemi incessanti in Grecia. Secoli di cattiva amministrazione erano costati alle città e alle fazioni greche l’indipendenza da Roma. La penisola e le isole erano diventate terreno di scontro per alcune delle più feroci guerre civili della tarda Repubblica, che portarono devastazione, un senso diffuso di impotenza e terrore. L’amministrazione imperiale aveva tentato di porvi rimedio, con risultati però limitati. Fin dalla giovinezza, Plutarco percepiva questo sottofondo di privazione nella realtà greca.
Punto da un sentimento di nazionalismo, il giovane coltivò il desiderio di sviluppare la forza della civiltà e della cultura ellenica. Era studioso e determinato nel raccogliere tutte le informazioni sul suo Paese che riuscisse a comprendere. Tuttavia, Plutarco ammirava Roma ed era affascinato dall’ascesa di quella civiltà un tempo oscura proveniente dall’Italia, sebbene alcune sue parti lo colpissero come rozze e prive di raffinatezza.
Tuttavia, possedeva molti altri talenti. Si sapeva che aveva una grande comprensione della matematica, che riuscì a soddisfare solo nei suoi vent’anni studiando ad Atene. Uno dei suoi insegnanti, Ammonio, che era un sacerdote, notò che Plutarco non era un ragazzo comune e che se la sua mente fosse stata rivolta verso gli Dèi, avrebbe potuto servirli in modo grande e illustre, instancabilmente. Questa previsione si rivelò corretta.
SACERDOTE DI APOLLO
Plutarco divenne infatti sacerdote di Apollo, un ruolo che descrive casualmente di sfuggita, affermando di aver condiviso la carica con Eutidemo. Il sito di Delfi era caduto in un certo abuso ai tempi degli Imperatori Romani dopo Augusto. Un tema particolare nelle sue opere è il desiderio di rinnovare il Tempio, che egli ripete costantemente fin dalla giovane età. Possiamo vedere che la ristrutturazione di questo luogo sacro fu una grande ossessione che volle portare a termine in tutte le fasi della sua vita.
Egli presiedette anche i Giochi pitici di Apollo, per i quali Adriano lo nominò organizzatore negli ultimi anni della sua vita.
I contributi di Plutarco al santuario di Delfi gli valsero un onore duraturo. In riconoscimento del suo servizio come sacerdote di Apollo e dei suoi sforzi per rivitalizzare Delfi, i delfici – insieme ai concittadini di Plutarco di Cheronea – eressero un busto di Plutarco e una stele iscritta nel museo di Delfi (stele a destra) in sua commemorazione. L’iscrizione riporta che “i delfici, insieme ai cheronei, dedicarono questo Plutarco, seguendo i decreti dell’Anfizionia”. Plutarco rimase devoto al culto di Apollo per decenni e il suo ruolo a Delfi esemplificò la continua vitalità della vita religiosa greca sotto il dominio romano.
OPERE TEOLOGICHE
Come sacerdote, scrisse molte opere di natura religiosa. Gran parte di queste sono contenute nelle sue Moralia, insieme a scritti di carattere più laico. La più famosa è Iside e Osiride, un’opera di cosmologia e metafisica egizia scritta dopo ampie discussioni con i sacerdoti. In quest’opera, tuttavia, fa anche numerosi riferimenti ad altre pratiche religiose, come quelle dei persiani.
Sulla E a Delfi è un racconto mistico sul tema della lettera E scolpita nel Tempio di Delfi, ma rappresenta anche un più ampio trattato sui misteri di Apollo, il Dio al quale Plutarco fu devoto per tutta la vita.
Sulla Superstizione era un'opera concepita per attaccare la stupidità della superstizione, ma anche i modi in cui gruppi umani eccessivamente arretrati e primitivi, insieme a persone malvagie nelle società avanzate, travisano gli Dèi. La differenza tra superstizione e la vera fede negli Dèi viene enfatizzata mentre Plutarco approfondisce la psicologia legata a tali questioni. Il sacrificio umano è ampiamente condannato come malvagio.
Il Dèmone di Socrate è ambientato durante la liberazione di Tebe ad opera di Epaminonda, mentre gli studenti si radunano nella casa di Simmia, un discepolo di Socrate. Qui discutono della natura del Dèmone Guardiano, riconoscendo che Socrate raggiunse l’eccellenza proprio seguendo sempre la sua guida.
Molte delle opere di Plutarco, tuttavia, non sopravvissero al cristianesimo.
TIMOSSENA
Plutarco era legato a sua moglie, Timossena, una donna aristocratica e di natura colta. Ebbero cinque figli, tre dei quali sopravvissero fino all’età adulta. Uno dei suoi dialoghi più toccanti fu scritto per consolarla dopo la perdita della loro figlia. In questo “Consolazione a mia moglie”, Plutarco consiglia dolcemente a Timossena di non lasciarsi andare a un dolore eccessivo, trovando conforto nella convinzione che l’anima della loro bambina fosse pura e che, nella sua breve vita, le avessero donato solo amore. La lettera menziona anche la precedente perdita di un giovane figlio di nome Cherone, a indicare che la coppia affrontò un dolore personale.
I suoi dialoghi fanno spesso riferimento alla virtù femminile. Fu uno degli autori più prolifici sul tema delle grandi donne, che catalogò nell’opera “Le virtù delle donne”. In questo dialogo, afferma anche la sua convinzione che le donne siano altrettanto preziose e grandi quanto gli uomini in coraggio, audacia, virtù e capacità, se viene loro permesso.
Si suppone talvolta che “Le virtù delle donne” fosse destinata a evolversi in un equivalente femminile delle Vite.
TEORIA SOCIALE
Plutarco coltivò un circolo molto ampio di amici e conoscenti, dai musicisti, ai medici, fino a principi siriani itineranti. Si circondava di stoici, epicurei, edonisti, pitagorici e molti altri. Ispirato dall’esempio di Socrate, per lui classe sociale, status, sesso e altre caratteristiche avevano poca importanza rispetto alla capacità di comunicare ed esprimersi, sebbene, essendo tecnicamente un equestre romano, dovesse talvolta mantenere una certa cautela. A differenza di molti filosofi citati nelle Personalità Zeviste, non mostrava tendenze ostili alla socializzazione.
Il sacerdote viaggiò ampiamente, seguendo l’esempio di Erodoto. Le descrizioni approfondite di Plutarco sull’Egitto e su altri luoghi esotici costituiscono gran parte delle informazioni che possediamo su questi paesi così come esistevano allora. Aveva inoltre amici che descrivevano in dettaglio i loro viaggi in India e in Britannia, cosa che egli annota nelle sue opere con acume, accanto alle sue stesse narrazioni di viaggio. Le sue osservazioni annotate sono state corroborate da prove archeologiche.
Il servizio pubblico di Plutarco si estese oltre Cheronea, verso l’intera regione e le antiche tradizioni della Grecia. In particolare, ricoprì un ruolo fondamentale nella Lega Anfizionica, il secolare consiglio che amministrava i santuari principali come quello di Delfi. All’inizio del II secolo E.V., Plutarco fu nominato epimelētēs (amministratore) della Lega Anfizionica per almeno cinque mandati, tra il 107 e il 127 E.V.
Socialmente e politicamente, Plutarco faceva parte dell’aristocrazia provinciale greca che prosperò sotto l’Impero Romano assumendo ruoli di leadership locale e cooperando con il governo imperiale. Queste élite locali spesso praticavano l’euergetismo, utilizzando la loro ricchezza per arricchire le loro città con edifici pubblici, festività e donazioni, in cambio di onore e prestigio.
TEORIA STORICA
Crescendo circondato da così tanti ego potenti, Plutarco sviluppò una teoria della storia secondo cui gran parte del corso degli stati dipende da personalità estremamente influenti e dal loro impatto sulla società. Questa è la genesi della cosiddetta Teoria del Grande Uomo. Storici precedenti come Erodoto, Senofonte e Callistene avevano certamente evidenziato la potente influenza dei Grandi Uomini (Senofonte scrisse una biografia di Ciro), ma Plutarco riteneva che il carattere, la moralità e le azioni di tali uomini meritassero un’analisi microscopica e un confronto con altri.
In questo fu molto influenzato dalla memoria recente dell’imperatore Augusto, così come dalle sue interazioni con l’Imperatore Vespasiano. Alessandro, che un tempo aveva attraversato a cavallo la città natale del Sommo Sacerdote, gli riecheggiò attraverso i secoli, diventando il soggetto che avrebbe costituito la sua più grande opera, le Vite Parallele.
VITE PARALLELE
Il suo magnum opus, le Vite Parallele, è una rinomata raccolta di biografie che accoppiano figure storiche greche e romane di rilievo per evidenziarne le virtù, il carattere e le lezioni morali. Composta intorno ai primi anni del II secolo E.V., ogni coppia solitamente contrappone un personaggio greco e uno romano, come Alessandro Magno con Giulio Cesare, o Demostene con Cicerone, per mettere in risalto somiglianze o differenze nel loro comportamento morale, nelle carriere politiche e nelle decisioni personali. L’obiettivo principale di Plutarco era l’istruzione morale, guidando i suoi lettori verso una riflessione etica attraverso esempi pratici tratti da leader e statisti famosi.
Ogni coppia di biografie si conclude con una breve analisi comparativa in cui Plutarco confronta esplicitamente le qualità morali, i successi e i fallimenti dei due individui. Questi confronti mettono in evidenza principi morali universali, illustrando virtù come il coraggio, la saggezza, la temperanza e la giustizia, così come vizi quali l’ambizione, la crudeltà e l’avidità. Plutarco miscela accuratamente narrazione, aneddoti e riflessioni filosofiche, assicurando che ogni biografia sia sia educativa che coinvolgente, mettendo in risalto il complesso intreccio tra carattere individuale e circostanze storiche.
Oltre ai suoi obiettivi filosofici, Le Vite Parallele è ora una delle opere più influenti della letteratura classica, avendo plasmato per secoli la percezione degli eroi antichi. I pensatori del Rinascimento e dell’età moderna europea si sono largamente ispirati alle rappresentazioni di Plutarco quando riflettevano su guida, etica e responsabilità civica. I ritratti coinvolgenti di queste figure storiche hanno offerto ai lettori lezioni senza tempo sulla natura umana e sulla moralità, consolidando così la reputazione di Plutarco come uno dei più grandi biografi dell’antichità, il cui lavoro continua a ispirare riflessioni etiche ancora oggi.
Purtroppo, tuttavia, alcune delle cinquanta Vite sono andate perdute. Epaminonda e Scipione l’Africano esistono solo in frammenti.
VITE DEGLI IMPERATORI ROMANI
Un altro progetto di Plutarco fu la raccolta delle Vite degli Imperatori romani, da Augusto a Vitellio. Si tratta di un insieme di opere per lo più perdute, con solo le Vite di Galba e Oto sopravvissute ad oggi
BIBLIOGRAFIA
¹ Plutarch, Moralia
Plutarco, Moralia
² Plutarch and His Times, R.H. Barrow
Plutarch, On Isis and Osiris
Plutarco, Iside e Osiride
CREDITO:
[TG] Karnonnos
PLUTARCO
Sommo Sacerdote di Apollo
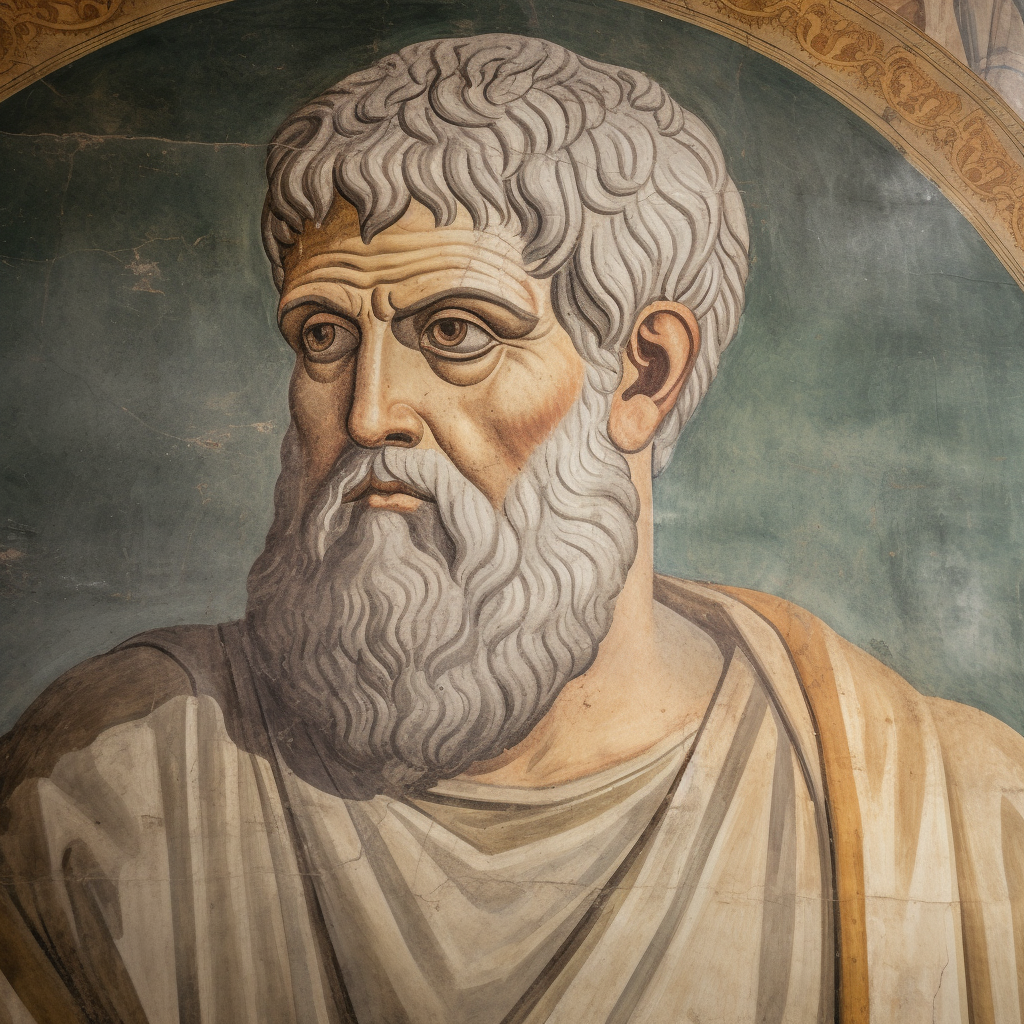
Il grande Plutarco si è fatto un nome nella storia come uno dei più celebri storici dell’antichità. È tuttora frequentemente citato in tutti i dipartimenti di storia e di studi classici. La sua serie delle Vite, che consiste in ampie biografie doppie di importanti figure dell’antichità, costituisce una parte straordinaria di ciò che sappiamo su quell’epoca. Il grande storico ha fornito instancabilmente, a generazioni di storici, conoscenze e contesto adeguati per comprendere la cultura degli Dèi.
Tuttavia, ai suoi tempi, Plutarco era soprattutto un Sommo Sacerdote di Apollo a Delfi, oltre che un autore di grande rilievo religioso e morale per i romani della sua epoca. Fu un pioniere in molti ambiti della conservazione culturale, storica e ambientale, sostenuto dal circolo dell’imperatore Vespasiano. In età avanzata, fu anche un associato dell’imperatore Adriano, che divenne suo benefattore e alleato nella promozione della cultura greca. Questo aspetto dello scrittore greco è stato comunemente dimenticato dalle masse, una questione che desideriamo correggere nel riconoscere l’immensa importanza di questo amico degli Dèi.
FIORE TRA LE ROVINE
Plutarco nacque a Cheronea, luogo della celebre battaglia di Filippo e Alessandro tre secoli prima. La sua famiglia era di rilievo e benestante, equivalente al rango equestre romano. Crescendo, fu estremamente legato ai suoi fratelli e venerava suo fratello Timone. Anche suo nonno Lampria compare nei suoi dialoghi, a testimonianza della stima che il giovane greco nutriva per la sua famiglia.
Suo padre, Autobulo, era un grande conversatore e uomo di società; spesso organizzava cene con personalità influenti tra i romani, alle quali il figlio curioso assisteva con vivo interesse. I resoconti di queste serate sarebbero poi divenuti oggetto dei cosiddetti libri Conversazioni a tavola di Plutarco. Fin da giovane, Plutarco fu affascinato dalle persone e dotato di una straordinaria coscienza sociale, con una memoria prodigiosa per volti, nomi e dettagli delle conversazioni, che il padre contribuì ampiamente ad alimentare:
Dalle Conversazioni a tavola e da altri scritti di Plutarco apprendiamo oltre un centinaio di nomi tra parenti, amici e conoscenti, uomini e donne. Alcuni di questi personaggi ci vengono delineati con notevole dettaglio; se ne possono intuire i caratteri, le competenze e gli interessi; altri risultano meno definiti. La maggior parte, naturalmente, porta nomi greci, ma sedici di loro hanno nomi romani, e alcuni di questi svolgono un ruolo molto rilevante nei dialoghi. ¹
In generale, le sue effusive riunioni familiari forniscono gran parte dello slancio alla sua produzione letteraria. Menziona che la sua famiglia celebrava festività in onore di Socrate e Platone, simili a quelle che saranno tenute da Proclo quattro secoli più tardi. Plutarco presenta molte delle sue opere come celebrative e nello spirito di un particolare calore, cosa che le rende, ancora oggi, trascendentemente leggibili.
Eppure, nonostante l’agiatezza dell’ambiente in cui crebbe, Plutarco nacque anche in un’epoca di grande inquietudine e problemi incessanti in Grecia. Secoli di cattiva amministrazione erano costati alle città e alle fazioni greche l’indipendenza da Roma. La penisola e le isole erano diventate terreno di scontro per alcune delle più feroci guerre civili della tarda Repubblica, che portarono devastazione, un senso diffuso di impotenza e terrore. L’amministrazione imperiale aveva tentato di porvi rimedio, con risultati però limitati. Fin dalla giovinezza, Plutarco percepiva questo sottofondo di privazione nella realtà greca.
Punto da un sentimento di nazionalismo, il giovane coltivò il desiderio di sviluppare la forza della civiltà e della cultura ellenica. Era studioso e determinato nel raccogliere tutte le informazioni sul suo Paese che riuscisse a comprendere. Tuttavia, Plutarco ammirava Roma ed era affascinato dall’ascesa di quella civiltà un tempo oscura proveniente dall’Italia, sebbene alcune sue parti lo colpissero come rozze e prive di raffinatezza.
Tuttavia, possedeva molti altri talenti. Si sapeva che aveva una grande comprensione della matematica, che riuscì a soddisfare solo nei suoi vent’anni studiando ad Atene. Uno dei suoi insegnanti, Ammonio, che era un sacerdote, notò che Plutarco non era un ragazzo comune e che se la sua mente fosse stata rivolta verso gli Dèi, avrebbe potuto servirli in modo grande e illustre, instancabilmente. Questa previsione si rivelò corretta.
SACERDOTE DI APOLLO
Plutarco divenne infatti sacerdote di Apollo, un ruolo che descrive casualmente di sfuggita, affermando di aver condiviso la carica con Eutidemo. Il sito di Delfi era caduto in un certo abuso ai tempi degli Imperatori Romani dopo Augusto. Un tema particolare nelle sue opere è il desiderio di rinnovare il Tempio, che egli ripete costantemente fin dalla giovane età. Possiamo vedere che la ristrutturazione di questo luogo sacro fu una grande ossessione che volle portare a termine in tutte le fasi della sua vita.
Sai che ho servito Apollo Pitico in molti festività pitiche; ma non mi diresti mai "Plutarco, hai sacrificato abbastanza e preso parte a processioni e cori; ora che sei vecchio è tempo che deponga la corona e rinunci all’interesse per l’oracolo, usando la tua età avanzata come motivazione...". ²
Egli presiedette anche i Giochi pitici di Apollo, per i quali Adriano lo nominò organizzatore negli ultimi anni della sua vita.
I contributi di Plutarco al santuario di Delfi gli valsero un onore duraturo. In riconoscimento del suo servizio come sacerdote di Apollo e dei suoi sforzi per rivitalizzare Delfi, i delfici – insieme ai concittadini di Plutarco di Cheronea – eressero un busto di Plutarco e una stele iscritta nel museo di Delfi (stele a destra) in sua commemorazione. L’iscrizione riporta che “i delfici, insieme ai cheronei, dedicarono questo Plutarco, seguendo i decreti dell’Anfizionia”. Plutarco rimase devoto al culto di Apollo per decenni e il suo ruolo a Delfi esemplificò la continua vitalità della vita religiosa greca sotto il dominio romano.
OPERE TEOLOGICHE
Come sacerdote, scrisse molte opere di natura religiosa. Gran parte di queste sono contenute nelle sue Moralia, insieme a scritti di carattere più laico. La più famosa è Iside e Osiride, un’opera di cosmologia e metafisica egizia scritta dopo ampie discussioni con i sacerdoti. In quest’opera, tuttavia, fa anche numerosi riferimenti ad altre pratiche religiose, come quelle dei persiani.
Sulla E a Delfi è un racconto mistico sul tema della lettera E scolpita nel Tempio di Delfi, ma rappresenta anche un più ampio trattato sui misteri di Apollo, il Dio al quale Plutarco fu devoto per tutta la vita.
Sulla Superstizione era un'opera concepita per attaccare la stupidità della superstizione, ma anche i modi in cui gruppi umani eccessivamente arretrati e primitivi, insieme a persone malvagie nelle società avanzate, travisano gli Dèi. La differenza tra superstizione e la vera fede negli Dèi viene enfatizzata mentre Plutarco approfondisce la psicologia legata a tali questioni. Il sacrificio umano è ampiamente condannato come malvagio.
Il Dèmone di Socrate è ambientato durante la liberazione di Tebe ad opera di Epaminonda, mentre gli studenti si radunano nella casa di Simmia, un discepolo di Socrate. Qui discutono della natura del Dèmone Guardiano, riconoscendo che Socrate raggiunse l’eccellenza proprio seguendo sempre la sua guida.
Molte delle opere di Plutarco, tuttavia, non sopravvissero al cristianesimo.
TIMOSSENA
Plutarco era legato a sua moglie, Timossena, una donna aristocratica e di natura colta. Ebbero cinque figli, tre dei quali sopravvissero fino all’età adulta. Uno dei suoi dialoghi più toccanti fu scritto per consolarla dopo la perdita della loro figlia. In questo “Consolazione a mia moglie”, Plutarco consiglia dolcemente a Timossena di non lasciarsi andare a un dolore eccessivo, trovando conforto nella convinzione che l’anima della loro bambina fosse pura e che, nella sua breve vita, le avessero donato solo amore. La lettera menziona anche la precedente perdita di un giovane figlio di nome Cherone, a indicare che la coppia affrontò un dolore personale.
I suoi dialoghi fanno spesso riferimento alla virtù femminile. Fu uno degli autori più prolifici sul tema delle grandi donne, che catalogò nell’opera “Le virtù delle donne”. In questo dialogo, afferma anche la sua convinzione che le donne siano altrettanto preziose e grandi quanto gli uomini in coraggio, audacia, virtù e capacità, se viene loro permesso.
Si suppone talvolta che “Le virtù delle donne” fosse destinata a evolversi in un equivalente femminile delle Vite.
TEORIA SOCIALE
Plutarco coltivò un circolo molto ampio di amici e conoscenti, dai musicisti, ai medici, fino a principi siriani itineranti. Si circondava di stoici, epicurei, edonisti, pitagorici e molti altri. Ispirato dall’esempio di Socrate, per lui classe sociale, status, sesso e altre caratteristiche avevano poca importanza rispetto alla capacità di comunicare ed esprimersi, sebbene, essendo tecnicamente un equestre romano, dovesse talvolta mantenere una certa cautela. A differenza di molti filosofi citati nelle Personalità Zeviste, non mostrava tendenze ostili alla socializzazione.
Il sacerdote viaggiò ampiamente, seguendo l’esempio di Erodoto. Le descrizioni approfondite di Plutarco sull’Egitto e su altri luoghi esotici costituiscono gran parte delle informazioni che possediamo su questi paesi così come esistevano allora. Aveva inoltre amici che descrivevano in dettaglio i loro viaggi in India e in Britannia, cosa che egli annota nelle sue opere con acume, accanto alle sue stesse narrazioni di viaggio. Le sue osservazioni annotate sono state corroborate da prove archeologiche.
Il servizio pubblico di Plutarco si estese oltre Cheronea, verso l’intera regione e le antiche tradizioni della Grecia. In particolare, ricoprì un ruolo fondamentale nella Lega Anfizionica, il secolare consiglio che amministrava i santuari principali come quello di Delfi. All’inizio del II secolo E.V., Plutarco fu nominato epimelētēs (amministratore) della Lega Anfizionica per almeno cinque mandati, tra il 107 e il 127 E.V.
Socialmente e politicamente, Plutarco faceva parte dell’aristocrazia provinciale greca che prosperò sotto l’Impero Romano assumendo ruoli di leadership locale e cooperando con il governo imperiale. Queste élite locali spesso praticavano l’euergetismo, utilizzando la loro ricchezza per arricchire le loro città con edifici pubblici, festività e donazioni, in cambio di onore e prestigio.
TEORIA STORICA
Crescendo circondato da così tanti ego potenti, Plutarco sviluppò una teoria della storia secondo cui gran parte del corso degli stati dipende da personalità estremamente influenti e dal loro impatto sulla società. Questa è la genesi della cosiddetta Teoria del Grande Uomo. Storici precedenti come Erodoto, Senofonte e Callistene avevano certamente evidenziato la potente influenza dei Grandi Uomini (Senofonte scrisse una biografia di Ciro), ma Plutarco riteneva che il carattere, la moralità e le azioni di tali uomini meritassero un’analisi microscopica e un confronto con altri.
In questo fu molto influenzato dalla memoria recente dell’imperatore Augusto, così come dalle sue interazioni con l’Imperatore Vespasiano. Alessandro, che un tempo aveva attraversato a cavallo la città natale del Sommo Sacerdote, gli riecheggiò attraverso i secoli, diventando il soggetto che avrebbe costituito la sua più grande opera, le Vite Parallele.
VITE PARALLELE
Il suo magnum opus, le Vite Parallele, è una rinomata raccolta di biografie che accoppiano figure storiche greche e romane di rilievo per evidenziarne le virtù, il carattere e le lezioni morali. Composta intorno ai primi anni del II secolo E.V., ogni coppia solitamente contrappone un personaggio greco e uno romano, come Alessandro Magno con Giulio Cesare, o Demostene con Cicerone, per mettere in risalto somiglianze o differenze nel loro comportamento morale, nelle carriere politiche e nelle decisioni personali. L’obiettivo principale di Plutarco era l’istruzione morale, guidando i suoi lettori verso una riflessione etica attraverso esempi pratici tratti da leader e statisti famosi.
Ogni coppia di biografie si conclude con una breve analisi comparativa in cui Plutarco confronta esplicitamente le qualità morali, i successi e i fallimenti dei due individui. Questi confronti mettono in evidenza principi morali universali, illustrando virtù come il coraggio, la saggezza, la temperanza e la giustizia, così come vizi quali l’ambizione, la crudeltà e l’avidità. Plutarco miscela accuratamente narrazione, aneddoti e riflessioni filosofiche, assicurando che ogni biografia sia sia educativa che coinvolgente, mettendo in risalto il complesso intreccio tra carattere individuale e circostanze storiche.
Oltre ai suoi obiettivi filosofici, Le Vite Parallele è ora una delle opere più influenti della letteratura classica, avendo plasmato per secoli la percezione degli eroi antichi. I pensatori del Rinascimento e dell’età moderna europea si sono largamente ispirati alle rappresentazioni di Plutarco quando riflettevano su guida, etica e responsabilità civica. I ritratti coinvolgenti di queste figure storiche hanno offerto ai lettori lezioni senza tempo sulla natura umana e sulla moralità, consolidando così la reputazione di Plutarco come uno dei più grandi biografi dell’antichità, il cui lavoro continua a ispirare riflessioni etiche ancora oggi.
Purtroppo, tuttavia, alcune delle cinquanta Vite sono andate perdute. Epaminonda e Scipione l’Africano esistono solo in frammenti.
VITE DEGLI IMPERATORI ROMANI
Un altro progetto di Plutarco fu la raccolta delle Vite degli Imperatori romani, da Augusto a Vitellio. Si tratta di un insieme di opere per lo più perdute, con solo le Vite di Galba e Oto sopravvissute ad oggi
BIBLIOGRAFIA
¹ Plutarch, Moralia
Plutarco, Moralia
² Plutarch and His Times, R.H. Barrow
Plutarch, On Isis and Osiris
Plutarco, Iside e Osiride
CREDITO:
[TG] Karnonnos

